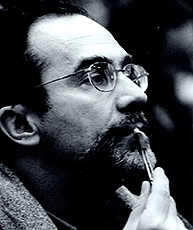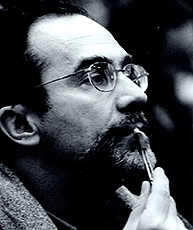|
LA SCREANZA (Mauro Macario, 2012)
Secondo il vocabolario si definisce “screanza” un’azione “sgarbata, scontrosa, che rivela maleducazione, inciviltà, rozzezza”. Un titolo realmente beffardo, questo che Mauro Macario ha trovato per il suo recente volume di versi (LA SCREANZA, liberodiscrivere, 2012) e che evoca, senza troppi sottintesi, la necessaria “ineducazione” dell’eresia poetica. Le poesie che qui leggiamo, malinconiche e infuriate, intime e sovversive, sono velenose punture nel cuore degradato della civiltà e dell’uomo, atti di accusa individuali e sociali che lasciano il segno, nella pagina: anzi la cicatrice. La lingua asciutta, antilirica, narrativa del poeta, il suo andamento irregolare e prosastico, sono armi in più perché le vibrazioni affettive ed etiche abbiano maggiore risonanza: “mentre in un grill / l’uomo disperso raccoglie i suoi resti / tra un caffè indecente e un silenzio nucleare / a quell’ora più non risponde / a voci attutite impastate di neon / paga e riparte / lo aspetta quel viaggio / senza casello d’uscita / lontanamente”). Macario, dopo le prove già intense e originali dei libri precedenti (ricordiamo almeno Cantico della resa mortale, Crimini naturali e Il destino di essere altrove), approda qui a una poetica che, pur intessuta nella retorica dell’invettiva, la trapassa da dentro per farsi grido mai placato di libertà, dolente testimonianza di un uomo offeso che non rinuncia ad essere “uomo”. La lingua sempre “sovratono” induce il lettore, come osserva Rodolfo di Biasio nella bella prefazione, a una “navigazione in apnea” del libro, fino all’ultimo respiro, a una lettura disperata e tesa come disperata e tesa è questa scrittura che al lirismo delle immagini preferisce la nuda provocatorietà dei fatti (lutti intimi o stermini globali). La poesia di Macario è una “scrittura a voce alta”, focosa, irruente, per sua natura interminabile: è la voce di un bambino adulto che reclama i suoi diritti e lo farà fino all’ultimo fiato, qualsiasi prezzo debba, dopo, pagare. Una voce traboccante pietas e nostalgia, che non vuole le stanze chiuse dell’intimismo ma la piazza aperta della rivolta, con un lettore-spettatore complice e appassionato.
Un poeta, Macario, molto lontano dagli scialbi manierismi stilistici che contraddistinguono certa innocua scrittura contemporanea. E che non teme di essere ingenuo seguendo le parole (quasi il proclama) di René Char: “Dì ciò il fuoco esita a dire e muori d’averlo detto per tutti”. La sua attenzione per le figure eretiche, i matti e gli anarchici (l’amato Leo Ferrè) è splendidamente evidente nella poesia Schumann non sapeva nuotare dedicata al grande musicista tedesco morto folle: “Tu non saprai mai / cosa vuol dire passare le stazioni / e non scendere da se stessi a nessuna / rimanendo sul posto con un biglietto scaduto / nel maltempo che imperversa al di là del corpo caduco / Schumann lo sa / salvato dai barcaioli e internato / nel manicomio di Endenich / morendo in sinfonia con le cose inapparse”.
La “screanza” di questo libro si conclude con un breve e intenso poema “sulla via dei Maestri / in dissolvimento salvifico / dall’Occidente mandibolare”, che evoca il viaggio-desiderio verso un “uomo nuovo”, verso la necessità di una ricomposizione spirituale. Gli ultimi sorprendenti versi del libro “io / finalmente / non io” sono il definitivo congedo da un mondo ottuso e crudele. Si attua così quanto dice il poeta, “che la saudade è madre del mondo / che un paese è solo un’idea / e non c’è patria per gli uomini inquieti”.
E se è vero che “la vita non è un film francese / loro non tornano / né al rallentatore / né a passo normale /semplicemente / vanno in un altro film”, Macario si augura che loro, gli eroi amati in tante stagioni della vita (cantanti, attori, poeti, uomini di cabaret e di teatro) non si spengano dentro quell’altro film come se non fossero mai esistiti ma restino, nella nostra memoria, così, semplicemente, per amore di finzione, per amore di vita e di verità, nella pausa di qualche verso, immortali.
|