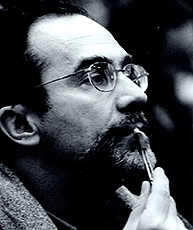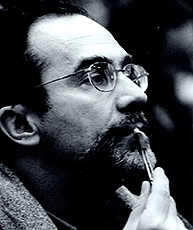|
RIFRAZIONI (Giuseppe Zuccarino, 2012)
Tornare a Praga significa esporsi a una certa reversibilità cronologica, sia quella di alcuni angoli della città, che sembrano sorgere intatti da un lontano passato storico, sia quella del proprio tempo biografico. Ad emblematizzare efficacemente tale sensazione, ci pensa l’orologio dell’antico Municipio di Josefov, che gira in senso antiorario. Ma pure nell’asserire ciò si torna indietro, ai versi di una delle più celebri poesie di Apollinaire: «Le lancette dell’orologio del quartiere ebraico vanno a ritroso / E anche tu indietreggi nella tua vita lentamente / Salendo al Hradschin e alla sera ascoltando / Nelle taverne cantare canzoni ceche».
È nota l’affermazione di Spinoza secondo cui «nessuno ha determinato finora quale sia il potere del corpo, cioè l’esperienza non ha finora insegnato a nessuno che cosa possa o non possa fare il corpo». Sorprende, però, vedere come Artaud, con l’audacia del delirio, si spinga ad attribuire un’analoga lacuna conoscitiva alla divinità: «Tu non sai / ancora / dio / cos’è il corpo! / cosa può essere un corpo!».
Sarebbe eccessivo voler generalizzare ciò che Mandel’štam dice di se stesso: «La mia memoria non è amorevole, ma ostile e lavora non a riprodurre ma a eliminare il passato». Tuttavia, quando egli fa riferimento agli «archivi di famiglia» e alle «epiche ricordanze domestiche», diventa senz’altro facile dargli ragione.
Oltre che un passatempo piacevole, la lettura può essere qualcosa di assai più serio e impegnativo. Chi la considera in questa seconda maniera, non resta stupito dalle frasi pronunciate dall’anziano Goethe: «La gente non sa quanto tempo e quanto sforzo costi imparare a leggere. Mi ci sono occorsi ottant’anni, e non sono neanche in grado di dire se ci sia riuscito».
Un argomento forte e persuasivo a favore di chi ama leggere resta quello indicato da Descartes: «La lettura di ogni buon libro è come una conversazione con gli ingegni più illustri che nei secoli passati ne sono stati gli autori, e per di più una conversazione privilegiata, nella quale essi ci svelano solo i loro pensieri più elevati». Quest’ultima osservazione è giusta pure in un altro senso: infatti, quando si legge, occorre tener conto anche delle cose «poco elevate» che gli scrittori non dicono esplicitamente (forse perché le giudicano troppo audaci, crudeli o rivelatrici), limitandosi a sottintenderle o ad alludervi di sfuggita.
Nelle ultime opere, Caravaggio accentua il proprio coinvolgimento nelle scene raffigurate. Così, nell’imponente Decollazione del Battista (1608), dipinta e conservata a Malta, non è certo un caso che la firma dell’artista (la cui presenza è di per sé eccezionale, visto che si tratta dell’unico quadro firmato) sia tracciata con il sangue che sgorga dalla gola recisa del santo. Ma è nel Davide con la testa di Golia (1609-10) che il messaggio diventa ancor più chiaro, giacché Caravaggio attribuisce i tratti del proprio volto alla testa mozzata del gigante. Al di là delle possibili interpretazioni in chiave biografica, collegando fra loro questi due dipinti si ottiene un’indicazione di portata simbolica generale: un artista (sia egli pittore o scrittore) firma col sangue di un decapitato che, a ben vedere, è lui stesso, quindi accetta che la propria vita trapassi (e si conservi soltanto) nelle opere che ha realizzato.
Secondo Canetti, «i pensieri che si articolano in un sistema sono senza pietà. Gradualmente escludono l’inespresso e poi se lo lasciano alle spalle finché muore di sete». I frammenti, all’opposto, non smettono mai di dialogare con quel che rimane non detto.
Benché il tentativo di affrontare razionalmente argomenti che per millenni avevano generato quasi solo credenze superstiziose sia senz’altro meritorio, occorre constatare che può condurre chi lo pratica a formulazioni insolite. Così, quando Kant intitola un paragrafo della sua Antropologia «Dell’invenzione involontaria nello stato di salute», non sarebbe certo facile per noi capire a cosa si riferisca, se non vi fosse l’aggiunta esplicativa: «cioè del sogno».
Un libro che si scrive è forse, come diceva Celan, «un messaggio nella bottiglia, gettato a mare nella convinzione – certo non sempre sorretta da grande speranza – che esso possa un qualche giorno e da qualche parte essere sospinto a una spiaggia». O forse ha ragione Quignard, quando, con illusioni ancora minori, sostiene: «Bisogna saper rispondere nel vuoto. Sono i libri. Bisogna saper perdersi nel vuoto».
Suscita simpatia la buffa e pessimistica osservazione di Wittgenstein: «Più invecchio più mi rendo conto di come sia difficile per le persone comprendersi reciprocamente, e secondo me ciò che ci trae in inganno è il fatto che sembriamo tutti tanto simili l’uno all’altro. Se alcuni avessero l’aspetto di un elefante e gli altri di un gatto, o di un pesce, non ci aspetteremmo di capirci a vicenda e le cose apparirebbero molto di più quello che sono in realtà».
Chi scrive frammenti ha spesso l’impressione che la vena si sia inaridita, o che per lui non vi sia più nulla da aggiungere. Ma, come osserva giustamente Sebald, «contro il vizio della scrittura non sembra esserci rimedio: coloro che ne sono caduti preda, vi si accaniscono persino quando la voglia di scrivere li ha già abbandonati da un pezzo».
Includere nei frammenti delle citazioni ha, come effetto secondario, quello di costituire, attraverso gli anni, una raccolta di frasi, scelte non con l’intento di dar vita a un florilegio, bensì solo per rispondere ad esigenze soggettive e momentanee. Dedicarsi a questa strana forma di collezionismo indiretto implica certo qualcosa di infantile. Leiris annota nel suo diario che, quando si sente incapace di scrivere, copia (oppure ritaglia e incolla) testi altrui, perché spera che ciò stimoli la sua immaginazione. D’altro canto, motiva questa pratica evocando il «gusto che hanno i bambini – o almeno che avevo io da bambino – di farsi dei quaderni, di riunire in un solo oggetto tutto ciò che può piacer loro».
L’inevitabile riproporsi, nel corso del tempo, degli stessi temi, fa sì che l’autore di una serie di frammenti possa dire, come Parmenide: «Indifferente è per me / il punto da cui devo prendere le mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare ritorno».
|